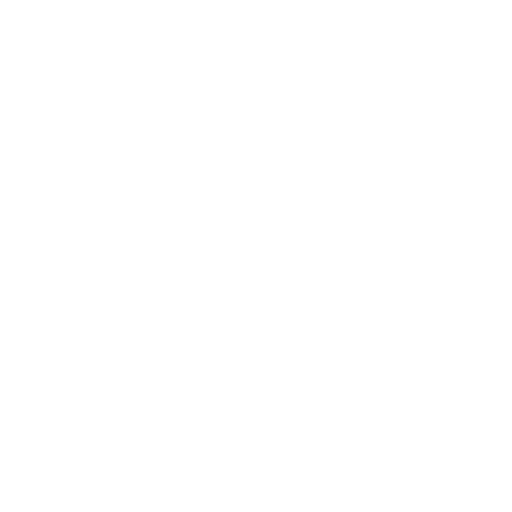Il palazzetto semivuoto di Tulsa come specchio dello smarrimento di Donald Trump

Lungi dal fare previsioni a 5 mesi dal voto in America, ma una cosa è chiara fin da ora: per Donald Trump il 2020 non assomiglia neanche lontanamente al 2016. Bastava trovarsi ieri a Tulsa, Oklahoma, per capirlo. Le aspettative per il suo primo comizio dall’inizio della pandemia erano altissime: e anche per questo gli spalti vuoti del palazzetto descrivono meglio di ogni altra immagine il momento di smarrimento della leadership americana.
Dal milione di prenotazioni per l’evento alla desolazione delle tribune senza pubblico. Dall’intervento previsto all’esterno alla cancellazione dello stesso causa scarsa partecipazione. Dai proclami su Twitter sul grande comizio di Tulsa alla furia di Donald con i malcapitati collaboratori per il flop andato in scena.
Qualcuno potrebbe minimizzare ricordando Pietro Nenni e il suo pluricitato “piazze piene, urne vuote”. Ma la storia di Trump, fino ad oggi, ha sempre detto il contrario: nel 2016, l’anno in cui sconfisse Hillary Clinton, i suoi comizi assomigliavano per partecipazione ai concerti di una rockstar in tour per l’America più che agli interventi di un candidato alla Casa Bianca.
Ora è chiaro che la paura del contagio abbia influito sulle presenze a Tulsa, e nessuno mette in dubbio che Trump sia in grado di mobilitare milioni di persone. Per quanto i sondaggi descrivano oggi un vantaggio solido di Joe Biden, perfino nei cosiddetti “Stati in bilico”, al punto da prevedere una vittoria a valanga del candidato Democratico, è troppo presto per dare per spacciato un Presidente in carica che gode del consenso quasi unanime della base del suo partito.
Resta però fortissima la sensazione di un Trump poco lucido, meno in sintonia con gli umori dell’America profonda, caratteristica che nel 2016 lo portò ad intercettare le paure e la voglia di rivalsa degli Stati rurali decisivi per la sua vittoria.
Per farsi un’idea, basta vedere come il Presidente ha trattato le proteste per la morte di George Floyd in queste settimane: prima ha temporeggiato sperando che il caso venisse archiviato da un’altra notizia, poi ha invocato l’esercito, dopo ha inaugurato una politica social contraddistinta dallo slogan “Legge e Ordine”, infine ha dovuto ammettere che anche nell’elettorato Repubblicano si è sviluppata una sensibilità importante su argomenti come il razzismo sistemico nei confronti delle minoranze etniche ed è stato costretto a varare un ordine esecutivo per incoraggiare la riforma della polizia, la stessa che aveva difeso a spada tratta fin dall’inizio della vicenda.
A Tulsa, oltre a prendere di mira Joe Biden, oltre a chiedere di rallentare coi tamponi perché fare tanti test significa trovare tanti positivi (la Casa Bianca ha poi precisato che stava scherzando, ma certo!), oltre a ribattezzare il coronavirus “Kung flu” (“flu” significa febbre: un chiaro gioco di parole razzista per associare l’epidemia ai Paesi asiatici), oltre ad elogiare la risposta della sua amministrazione al coronavirus (viva la modestia e l’onestà, soprattutto), Donald Trump non ha trovato il tempo per spendere una parola su George Floyd. Un’ora e quaranta minuti d’intervento, poco meno del record di 123 minuti registrato a dicembre, dopo che la Camera aveva votato per il suo impeachment (e che volete, Trump è un po’ ossessionato dalle sue sorti). E non un commento, una parola di cordoglio, un pensiero alla famiglia Floyd.
Non è soltanto strizzare l’occhio al suprematismo bianco, è dimostrare di non essere connesso con un popolo che marcia da settimane, per non dire da decenni, in cerca di legittimazione e diritti. Non significa essere solo un tantino egocentrico, vuol dire semplicemente essere troppo presi da se stessi per guidare l’America. No, il 2020 non sembra proprio il 2016. Io lo spero.