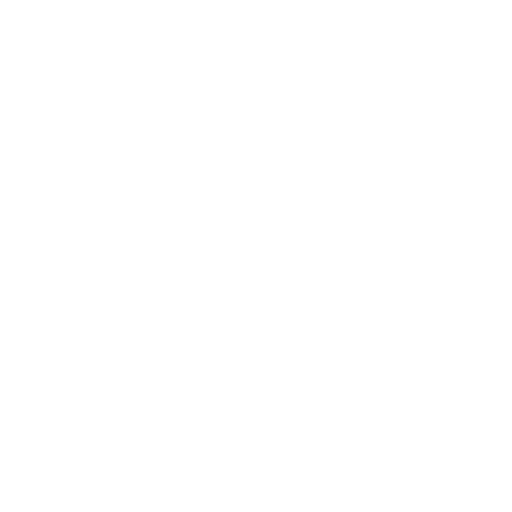Era Giovanni Falcone

“Ma come si fa a morire così, Cristo? Ma che ci misero? ‘A bomba atomica ci misero?“. Giovanni Falcone è da poco saltato in aria sulla Fiat Croma Bianca su cui viaggiava insieme alla moglie Francesca Morvillo e all’autista Giuseppe Costanza.
Sono le 17:58 di 30 anni fa a Capaci, Palermo, Italia, il “Paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l’hai fatta esplodere“. Falcone ha compiuto da pochi giorni 53 anni: potenzialmente tutta la vita davanti.

“L’Italia è in lutto“, tuona un giovane Enrico Mentana al Tg5. Chissà se lo era davvero tutta, quel 23 maggio 1992. Una sua parte, più che a piangere la morte del giudice, era impegnata a pensare a quale spettacolare risposta offrire ad un’opinione pubblica, lei sì, sconvolta dall’accaduto.
Perché andava sempre così, parola di Falcone. Dopo un omicidio eccellente, arrivava la telefonata dall’alto commissario per la lotta alla mafia del tempo. Dopo una sequenza di delitti condensati nello stesso giorno, chiamava il ministro dell’Interno “quasi quasi addebitandomi la responsabilità di quella esplosione di violenza“. Ne deriva che l’impegno dello Stato nella lotta alla criminalità risultasse “emotivo, episodio, fluttuante“. L’esatto opposto dell’approccio metodico di Giovanni Falcone nella sua guerra alla mafia.
Scrupoloso, quasi “matematico“, dotato di una memoria da elefante, di una sensibilità fuori dal comune, che gli consente di comunicare nel “codice” dei mafiosi, di ricavare da loro informazioni di enorme interesse investigativo. Ai pentiti, Falcone, porta rispetto. E da essi è rispettato. Li mette alla prova, ed è a sua volta “pesato“. Falcone è pragmatico, preparato: non chiede a chi gli sta di fronte di parlargli genericamente di Cosa Nostra. No, chiede conto di fatti precisi, dati alla mano, per saggiare l’affidabilità dell’interlocutore, per dimostrare la considerazione dello Stato nei confronti di tali informatori. Il tutto allo scopo di ricevere indicazioni utili alla sua lotta senza quartiere contro la mafia..
Ecco, un personaggio così, quel Falcone che nel 1986 imbastisce il Maxiprocesso, quello che mette alla sbarra 474 imputati, quello che non si ferma neanche dinanzi al discredito che alcune lettere anonime firmate da un “corvo” cercano di gettare sul suo conto, va eliminato. Sarà Giovanni Brusca, l’uomo che azionò il detonatore a Capaci, a svelare nelle vesti di pentito che a pochi giorni dal Natale 1991, nel corso di una riunione, venne pronunciata la condanna a morte per il dottor Falcone. “Totò Riina disse che dovevano morire tutti, che si voleva vendicare, che i politicanti lo stavano tradendo. Fece i nomi di Falcone, che era un suo chiodo fisso, di Borsellino, di Lima, di Mannino, di Martelli, di Purpura. Disse “gli dobbiamo rompere le corna”. Tutti ascoltavano in silenzio. Per amore o per timore“.
I mafiosi svolgono sopralluoghi lungo l’autostrada, si dotano di esplosivi, telecomandi, scelgono un tunnel in cui posizionare 1000 kg di tritolo. E quando il 23 maggio Falcone arriva a Palermo, dall’aeroporto di Punta Raisi ne seguono ogni spostamento in collegamento telefonico.
“Futtitinni, Giovanni! Futtitinni! Futtitinni della mafia, di Cosa Nostra, dei morti ammazzati che attendono giustizia. Futtitinni dello Stato. Pensa a tia! A to’ mugghieri, alla tua vita“. Nessun rimpianto in questo senso: nessun consiglio di questo genere avrebbe fatto breccia nella mente di Giovanni Falcone. E non perché il magistrato avesse poi tutta questa voglia di morire. No, macché. Di diventare un martire, Giovanni, non aveva intenzione alcuna. Per questo aveva invocato a più riprese delle riforme che mettessero i magistrati nella condizione di svolgere un proficuo lavoro di gruppo, consapevole che l’eccesso di personalizzazione avrebbe portato con sé “i rischi della sovraesposizione“. Il punto era che Falcone amava il suo lavoro, credeva nello Stato e nella giustizia.
Parlando dell’attentato a Rocco Chinnici, fatto saltare in aria da Cosa Nostra con una Fiat 126 parcheggiata davanti casa stracolma di esplosivo, Falcone commentò: “È stato scritto: ‘Essi hanno voluto sopprimerlo alla libanese per gettare Palermo nel terrore’. In realtà, essi l’hanno ucciso nel solo modo possibile, cusando cinque morti e distruggendo una decina di automobili perché Chinnici era molto prudente e attento in tema di sicurezza personale. Impariamo a riflettere in modo sereno e ‘laico’ sui metodi di Cosa Nostra: prima di sferrare l’attacco, l’organizzazione compie sempre uno studio serio e approfondito“, operando quelle che lui stesso definì “considerazioni tecniche e strategiche“.
Un “semplice” lavoro da compiere, insomma, realizzato da una “istituzione” alla quale Falcone attribuiva “la forza di una Chiesa“, sottolineando non a caso come uno dei suoi capi, Michele Greco, fosse soprannominato “il Papa“. La mafia, scriveva Falcone, minaccia qualcuno solo quando lo ritiene sensibile alle minacce. Perché “la mafia è razionale, vuole ridurre al minimo gli omicidi. Se la minaccia non raggiunge il segno, passa a un secondo livello, riuscendo a coinvolgere intellettuali, uomini politici, parlamentari, inducendoli a sollevare dubbi sull’attività di un poliziotto o di un magistrato ficcanaso, o esercitando pressioni dirette a ridurre il personaggio scomodo al silenzio. Alla fine ricorre all’attentato. Il passaggio all’azione è generalmente coronato da successo, dato che Cosa Nostra sa fare bene il suo mestiere“.
Aveva ragione, il giudice Falcone. Sapeva tutto. Sapevano, anzi. Lui e l’amico fraterno Paolo Borsellino. Insieme esorcizzavano il proprio destino. “Giovanni“, gli disse una volta, “devi darmi immediatamente la combinazione della cassaforte del tuo ufficio“. “E perché?“, rispose Falcone. E Borsellino: “Sennò quando ti ammazzano come l’apriamo?“. Quando, non se.

Diceva Falcone che “si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere“.
Io ho 30 anni, come quelli passati dalla sua morte. E nulla riesce a togliermi dalla testa che Giovanni Falcone avesse ragione. E che oggi, dopo tutto questo tempo, non sarebbe fiero di ciò che lo Stato è stato.