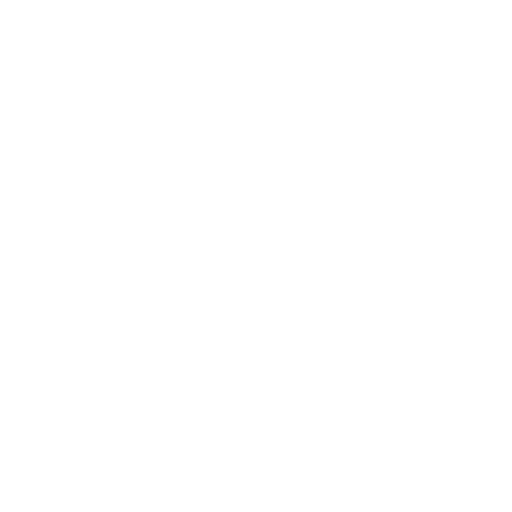SPECIALE DONALD TRUMP – Dall’assalto a Capitol Hill all’incriminazione -1^ PARTE

Siete davvero sicuri di voler conoscere la verità? Non vi spaventa l’idea? Non temete di scoprire che il sistema che regola le vostre vite è più fragile di quanto pensate? Perché questa non è – solo – la storia di Donald Trump e della sua incriminazione. Questa è la storia di come la più grande democrazia del Pianeta ha vacillato, rischiando di finire in frantumi. E con essa il mondo per come fino ad oggi lo avete conosciuto.
SPECIALE DONALD TRUMP: I RETROSCENA PRIMA DELL’ASSALTO A CAPITOL HILL
Gennaio 2021. Donell Harvin, direttore dell’intelligence per la sicurezza di Washington DC, è nel suo ufficio, sulle soglie della disperazione. Da giorni i suoi uomini raccolgono informazioni che non ammettono repliche: migliaia di estremisti, provenienti da tutto il Paese, hanno intenzione di marciare su Capitol Hill. Vogliono impedire che Joe Biden venga proclamato presidente. Ma se gli alert non hanno bisogno di interpretazioni, tanto sono chiari, se danno conto di un pericolo imminente, allora perché le agenzie federali non lo ascoltano?

È così che l’uomo appassionato del suo lavoro, il giovane funzionario di cui nessuno conosce il nome, compie la giocata che – spera – cambierà la partita. È un sabato, è il secondo giorno dell’anno, quando impugna il telefono e chiama il suo collega di San Francisco, Mike Sena, svegliandolo prima dell’alba.
Donell Harvin è un fiume in piena: mette in fila, una dopo l’altra, tutte le minacce che il Paese sta accingendosi ad affrontare, a suo dire senza adeguata preparazione. Perché è questo il problema: l’America sta andando a sbattere, e con lei il mondo libero. Ma nessuno, o quasi, sembra averlo compreso.
Eppure Mike Sena lo ascolta, in un attimo scende giù dal letto, e prende attentamente nota. D’un tratto capisce che quanto andato in scena nel suo ufficio della California settentrionale nelle ultime settimane, la marea di segnalazioni che lo ha inondato, non è frutto di un episodio isolato ma il sintomo di un malessere più preoccupante e diffuso.
È da questa consapevolezza che prende vita l’idea: perché non convocare una “call” fra tutti i vertici regionali della sicurezza statunitense? I tanto bistrattati “centri di fusione”, spesso guardati dall’alto in basso dai colleghi delle agenzie federali, possono essere la chiave per risolvere una minaccia alla sicurezza nazionale? Forse no, perché gli apparati di sicurezza sono pensati in maniera stratificata: nessuno può essere l’eroe solitario della storia, ma la partecipazione alla riunione organizzata da Sena è un segnale di quanto questa sfida sia grande. Di quanto tutti debbano muoversi, ed in fretta, per salvare il salvabile.
Mike Sena immagina di ritrovarsi a parlare con al massimo venti colleghi. Per questo rimane a bocca aperta quando, di minuto in minuto, il numero di colleghi aumenta vertiginosamente: prima sono 100, poi sono 200, infine sono quasi 300. Si collegano da ogni angolo del Paese. E lo fanno perché tutti hanno segnato sul calendario di rosso la stessa data: il 6 gennaio 2021.
Poi c’è lui. Poi c’è Donald Trump.

Durante la campagna elettorale, le allusioni al fatto che il sistema elettorale possa non essere a prova di brogli sono state pressoché quotidiane. Ma che ci sia un disegno più raffinato nelle parole del presidente uscente lo si intuisce più chiaramente il 26 settembre, durante un comizio in quel di Harrisburg, in Pennsylvania.
È in quella circostanza che The Donald pare mettere le mani avanti. Chiede una vittoria larga ai suoi elettori. E non c’è nulla di strano per un candidato che cerca di mobilitare la sua base. Ma poi aggiunge un particolare. Dice di non avere nessuna voglia di “tornare al Congresso, anche se lì abbiamo un vantaggio. Lo capite tutti?“. Dal pubblico, in realtà, sono in pochi ad ululare in segno di conferma. Perché ciò che Trump sta suggerendo non è così immediato. Sta infatti ipotizzando che sia la Camera dei Rappresentanti, e non il Collegio elettorale, ad indicare, stato per stato, il vincitore delle presidenziali. È un’eventualità remota, eppure possibile, che si attiva in caso di parità tra i candidati. Il leader dei Repubblicani deve però averla già esplorata a dovere, perché sostiene che in questo particolare scenario la sua candidatura sia avanti rispetto a quella di Biden, “26 a 22, o qualcosa del genere“. Cosa sta bollendo nel calderone trumpiano?
Passano tre giorni dal comizio in Pennsylvania, e la retorica di Trump si fa stavolta più minacciosa. Del primo dibattito presidenziale, oltre alla confusione di un confronto sfuggito di mano al moderatore, resta infatti soprattutto la domanda del giornalista Chris Wallace. O meglio, la risposta a quel quesito. Il reporter navigato chiede a Trump se sia pronto a condannare i suprematisti bianchi e i gruppi di estremisti che nell’estate del 2020 hanno riportato in auge violenze ed omicidi di matrice razziale nelle città americane. Il presidente ci girà un po’ intorno, la prende larga, mette nel mirino i radicali della sinistra Antifa, e poi sfida a sua volta: “Fammi un nome!“. A fare quel nome è Joe Biden, reattivo come poche altre volte lo si sarebbe visto nel corso di quella campagna elettorale: “Proud Boys, Proud Boys!“, lo incalza, riferendosi all’organizzazione di estrema destra nota per la sua ideologia violenta. Trump ci pensa sù un secondo, e poi realizza un capolavoro di inquietante ambiguità: “Proud Boys, fate un passo indietro e tenetevi pronti“.
Cos’ha appena detto il presidente americano? Ha chiesto ad un’organizzazione fascista di farsi trovare pronta? E a quale scopo? La risposta può suscitare soltanto speculazioni. Perché Trump sarà anche Trump, con tutti i suoi difetti e le sue esagerazioni, ma quasi nessuno in quei momenti sembra credere davvero che il leader dei Repubblicani sia disposto a tutto, veramente a tutto, pur di non abbandonare la Casa Bianca. Bisogna perciò attendere il giorno dello spoglio, le primissime ore del mattino successivo all’Election Day, per comprendere che The Donald non se ne andrà con le buone. In particolare, si deve aspettare la conferenza stampa che Trump tiene davanti al suo team di fedelissimi nell’East Room della residenza presidenziale. È in quella sala, in quel preciso istante, che il presidente manifesta le sue intenzioni: “Questa è una frode. Ci stavamo apprestando a vincere queste elezioni. Francamente, abbiamo vinto queste elezioni“.
Il popolo di Trump, dinanzi a quelle parole, si sente chiamato in causa. Manifestazioni spontanee hanno luogo all’esterno dei seggi, degli uffici governativi. E non sempre sono pacifiche. D’altro canto i Democratici iniziano a preoccuparsi. È chiaro a tutti che Donald Trump abbia perso il voto. Ma è vero anche che è andato meglio di quanto i sondaggi della vigilia avessero ipotizzato in molti Stati. Altro elemento: i Repubblicani hanno guadagnato dei seggi alla Camera. E Nancy Pelosi, speaker della House, è troppo esperta per non capire cosa questo significhi. Le parole pronunciate da Trump in quel comizio in Pennsylvania risuonano ora come un memento: The Donald ha una strada verso la presidenza. Deve “solo” contestare il risultato del Collegio elettorale. E per farlo ha bisogno di un uomo, di quello che considera il suo uomo. Ha bisogno di Mike Pence.
Mancano 48 giorni al 6 gennaio. Donald Trump è sempe più nervoso. I suoi consiglieri più vicini, gli alleati di lunga data come Rudy Giuliani, Steve Bannon o l’avvocato Sidney Powell sussurranno al suo orecchio le teorie più strampalate. Arrivano ad esempio a suggerirgli che il voto potrebbe essere stato manipolato dall’estero, che alcuni software utilizzati per votare avrebbero “pesato” le schede in modo che i voti per Biden risultino maggiori dei suoi, addirittura evocano legami con il Venezuela di Maduro. E Trump cavalca l’onda, anziché placarla. Ai suoi chiede di indagare, di trovare prove che testimonino l’influenza di Paesi stranieri, su tutti l’ossessione cinese. “Non possiamo permettere che questo accada a noi“, dice Rudy Giuliani davanti ai giornalisti, “non possiamo permettere a questi truffatori, perché è questo che sono, di rubare un’elezione al popolo americano. Hanno eletto Donald Trump. Non hanno eletto Joe Biden. Joe Biden è in testa a causa delle schede elettorali fraudolente“.
Si procede con questo schema per giorni. Trump parla apertamente di frode, si rende megafono delle tesi più assurde, provocando imbarazzo anche all’interno della parte sana del Partito Repubblicano. Fra queste c’è anche Liz Cheney. Nessuno provi a dire che la figlia di Dick, l’ex vicepresidente di George W. Bush, sia “una di loro”, una democratica. La mattina del 12 dicembre è nella sua cucina, sta guardando al computer le immagini di migliaia di sostenitori e manifestanti pro-Trump confluiti in quel di Washington per protestare come quella che ormai viene ribattezzata “la grande frode”. Non crede ai suoi occhi.

È in quel momento che i suoi pensieri corrono al 6 gennaio: “Quel giorno dobbiamo contare i voti“, dice preoccupata a sé stessa. Ed è sempre in quel momento che decide di riunire 10 ex segretari della Difesa, provenienti da amministrazioni repubblicane e democratiche, per firmare un editoriale sul Washington Post che metta in guardia i funzionari militari dal voler tentare di utilizzare l’esercito per mettere i bastoni tra le ruote ad uno dei pilastri della prassi democratica a stelle e strisce: il pacifico trasferimento di poteri.
Ma forse è già tardi. Il tono dei messaggi dei manifestanti sui social è cambiato. Non si tratta più di un’amarezza circoscritta alla normale delusione per un’elezione persa. C’è chi crede che in discussione ci sia il destino della nazione, c’è chi pensa che questa vada difesa, e che se necessario sia giusto immolarsi per essa.
Mike Pence farebbe volentieri a meno di tutte le attenzioni che gli vengono rivolte, ma non può farlo. Trump gli ripete puntualmente cosa si aspetta da lui. E all’inizio sembra quasi corteggiare il suo vicepresidente. “Sai, i miei collaboratori mi dicono che hai più potere di quanto pensi“, gli ripete in un incontro pochi giorni prima di Natale. Ma Pence gli risponde sempre alla stessa maniera: gli dice che è pronto a valutare qualsiasi argomentazione che provi che l’elezione di Biden può essere contestata, ma a patto che sia credibile, che gli dia realmente modo di bloccare la certificazione dei voti nella sessione congiunta del 6 gennaio.
In quelle giornate, poi, c’è anche chi alimenta la fiamma. Mark Meadows, capo dello staff di Trump, dietro le quinte fa il doppio gioco. Con Pence assume un tono conciliante: “Sappiamo come vanno queste cose. Calmeremo il tutto. Non si preoccupi. Stiamo abbassando la temperatura“. Ma poi quando entra nello Studio Ovale dice a Trump l’esatto opposto: “Sto dicendo a Pence che deve farlo. Pence lo farà. Sarà fantastico“.

A tre giorni da Natale, nella prima teleconferenza che prende in esame le misure di sicurezza da intraprendere il 6 gennaio, è il più giovane analista dell’ufficio il funzionario incaricato di valutare il livello di minaccia. È Donell Harvin, quel Donell Harvin, l’uomo da cui questo racconto ha avuto inizio. È lui a ricevere reports di messaggi ogni giorno più violenti, a dire ai suoi superiori che estremisti provenienti da diverse parti del Paese stanno organizzando la logistica, mobilitando un piccolo esercito, scambiandosi consigli su come contrabbandare armi a Washington. Il 30 dicembre, durante un’altra riunione, Harvin si spinge anche oltre: qualcuno, dice, potrebbe addirittura piazzare un ordigno esplosivo improvvisato vicino al Campidoglio. Con le forze dell’ordine distratte, gli estremisti potrebbero unirsi, attaccare gli edifici governativi, forse anche Capitol Hill. Ma il punto è che l’antiterrorismo americana non è adeguatamente formata per decifrare e rispondere alle minacce domestiche. Dopo l’11 settembre ogni comparto di sicurezza è stato votato alla prevenzione dei rischi provenienti dall’esterno, per evitare un altro shock, quello di un’America attaccata sul suo territorio. Qui lo scenario è differente: l’America sta per essere attaccata dai suoi cittadini. E nessuno è pronto per questo.
Tra i messaggi più ambigui, o forse più chiari in assoluto tra i tanti postati da Trump in quelle settimane ce n’è uno che finisce per infiammare la sua base più di altri nel mese di dicembre: “Grande protesta a Washington DC il 6 gennaio. Siateci, sarà selvaggio!“. Lo stesso giorno l’FBI riceve una telefonata che li avverte: alcuni sostenitori del presidente stanno pianificando di arrivare a Washington e sequestrare i parlamentari. La minaccia è in molti casi circoscritta. Su un documento del Federal Bureau si indica infatti come specifico obiettivo un senatore dello Utah che non è propriamente un signor nessuno: si chiama Mitt Romney, è un Repubblicano vero, nel 2012 ha corso e perso contro Barack Obama per la Casa Bianca. Ed è anche una delle poche voci critiche nel Gop nei confronti di Donald Trump.

Il 2 gennaio è proprio lui a ricevere da un collega del Senato la notizia che circolano online minacce da non prendere sotto gamba. Quando torna a casa ed informa sua moglie Ann, la risposta ha in sé un enorme rispetto nei confronti dello Stato: “Mitt, non puoi tornare indietro“.
In quelle ore Donald Trump è pienamente concentrato nel tentativo di ribaltare l’esito delle elezioni. In una telefonata del 27 dicembre a Jeffrey Rosen, procuratore generale subentrato a William Barr dopo le dimissioni del titolare del Dipartimento di Giustizia, chiede espressamente di stare al gioco: “Dica che le elezioni sono state corrotte e lasci a me il resto“. Ma i suoi sforzi maggiori si concentrano su Mike Pence. Il 4 gennaio i due si incontrano allo Studio Ovale alla presenza di John Eastman, avvocato ascoltatissimo da Trump ed ex preside della facoltà di legge alla Chapman University.

È lui a convincere Trump che si tratti solo di una questione di volontà: il vicepresidente può esercitare i suoi poteri sul processo di certificazione del voto, può congelare il Collegio elettorale, ritardare il conteggio ed in definitiva portare alla proclamazione di Trump come presidente. Ma quando Pence chiede ad Eastman in maniera diretta se per legge il vicepresidente ha oppure no il potere di decidere quali voti conteggiare, la risposta del professore è che questa è “una questione aperta“. Come d’improvviso, Pence intravede un salvagente in mezzo all’oceano. Guarda Trump: “L’hai sentito, vero?“. Ma da quell’orecchio, Donald Trump, ha smesso di sentire da tempo. La sera del 5 gennaio, dallo Studio Ovale, Donald Trump può ascoltare i cori dei suoi sostenitori radunati ad un paio di isolati di distanza: “Basta, lo sentite? Questa è una musica incredibile“, dice il presidente ai suoi. Poi detta un tweet a Dan Scavino, il numero due del suo gabinetto, seduto accanto al camino scoppiettante: “Washington sta per essere inondata di persone che non vogliono vedere una vittoria elettorale rubata. (…) Il nostro Paese ne ha avuto abbastanza. (…) Vi sento (e vi amo) dallo Studio Ovale. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!“.
Alcuni minuti dopo, Trump avrebbe chiesto ad un assistente: cosa pensi che la folla voglia sentire al comizio? L’uomo dello staff avrebbe suggerito di mettere in risalto i suoi risultati da presidente: “Voglio dire, hai avuto quattro anni incredibili!“. “No, no“, lo avrebbe infine interrotto Trump, “queste persone sono arrrabbiate“. Nessuno ha mai capito il suo popolo come Donald Trump.
Questo articolo è la prima parte dello SPECIALE DONALD TRUMP, un approfondimento del Blog finalizzato a ricostruire la parabola dell’ex presidente prima dei fatti del 6 gennaio, durante l’assalto a Capitol Hill e nelle settimane, nei mesi e negli anni successivi. Fino all’ultima incriminazione. L’indagine si basa su diverse fonti, in particolare su un’inchiesta del Washington Post realizzata intervistando più di 230 persone e consultando migliaia di documenti. La prima parte, quella appunto dedicata ai fatti PRECEDENTI al 6 gennaio è disponibile eccezionalmente per tutti i lettori. Le prossime puntate, sul DURANTE e DOPO, saranno consultabili integralmente dai soli iscritti al Blog.
Dietro un pezzo del genere ci sono 3 giorni di lavoro senza sosta. Chi apprezza i miei sforzi, chi vuole avere accesso alle prossime puntate, si iscriva: https://steadyhq.com/it/dangelodario